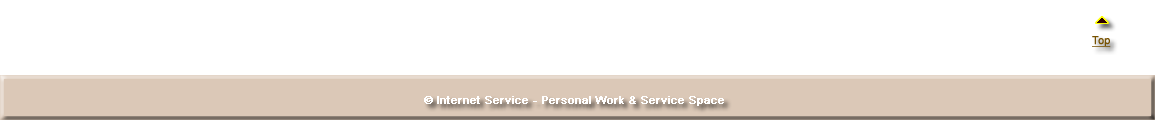60) Cosa insegna la Chiesa circa il suicidio?
Al riguardo è interessante un testo scritto da S. Agostino, che si intitola La città di Dio e che è utile conoscere. Ma chi era S. Agostino? Aurelio Agostino (Tagaste, Numidia 354 - Ippona 430) è uno dei piú eminenti padri e dottori della Chiesa. Figlio di padre pagano e di madre cristiana, nel 371 Agostino si recò a Cartagine per compiervi gli studi di retorica. Qui ebbe un figlio, Adeodato, da una donna con la quale visse in concubinato per circa quindici anni. All'età di diciannove anni, in seguito alla lettura dell'Ortensio di Cicerone, Agostino riconobbe in sé la vocazione alla filosofia; dopo breve tempo, aderí al manicheismo, religione di origine persiana largamente diffusa in Africa settentrionale. Insegnò grammatica e retorica dal 373, prima a Tagaste, poi a Cartagine.
Nel 383 si recò a Roma, dove sperava di trovare migliori possibilità di carriera. A Roma, tuttavia, Agostino rimase poco piú di un anno. Nell'autunno del 384 si trasferí a Milano, avendo ottenuto, grazie all'aiuto di alcuni amici manichei, l'incarico di professore ufficiale di retorica della città. L'esperienza milanese segnò una svolta radicale nella vita e nel pensiero di Agostino. L'incontro con il vescovo della città, Ambrogio, dal quale apprese il valore dell'esegesi allegorica delle Scritture, e la scoperta dei testi dei filosofi neoplatonici, in particolare le Enneadi di Plotino, nella traduzione latina del retore Mario Vittorino, contribuirono alla sua conversione al cristianesimo. Divenuto catecumeno nel 385, Agostino ricevette il battesimo dalle mani del vescovo Ambrogio nel 387.
Accostandosi al pensiero dei neoplatonici, Agostino intuí la superiorità filosofica del cristianesimo, che risolve il problema del male rivelandolo quale privazione o assenza del bene o dell'essere, e non quale principio sostanziale paritetico ma opposto ad esso, come invece avevano fatto i manichei. Su tali basi la filosofia, intesa come vera conoscenza dell'essere, può illustrare razionalmente ciò che per la fede è certezza assoluta, mettendo a fuoco il cuore di ogni uomo: secondo Agostino, infatti, il percorso svolto nell'interiorità dell'anima verso il riconoscimento della verità della fede corrisponde al cammino di salvezza che il cristianesimo propone e incarna.
Tornato a Tagaste nel 389, Agostino si dedicò allo studio e alla meditazione. Nel 391 venne ordinato sacerdote e nel 397 fu nominato vescovo di Ippona, in un periodo di gravi disordini politici e conflitti teologici: i barbari premevano ai confini dell'impero, mentre la Chiesa era minacciata da scismi ed eresie. Agostino si dedicò cosí alla lotta contro le eresie. Fra il 426 e il 427 Agostino compose le Ritrattazioni, in cui giudicò retrospettivamente tutte le proprie opere, revisionandole e arricchendole. Tra gli altri suoi scritti vi sono le Epistole, che abbracciano il periodo compreso fra il 386 e il 429, i trattati su Il libero arbitrio (388-395), La dottrina cristiana (397-426), Sul battesimo contro i donatisti (401), La Trinità (399-419), Sulla grazia contro Pelagio (415), e numerosi studi su vari libri della Sacra Scrittura, in particolare sul libro della Genesi. Ecco ciò che scrive Agostino circa il suicidio in un testo certamente severo ma sincero:
«Non senza ragione nei libri santi e canonici mai si può trovare il precetto o il permesso divino di inferire la morte a noi stessi, né per raggiungere la stessa immortalità, né per liberarci da qualche male o per prevenirlo. Dobbiamo intendere infatti che riguarda anche noi la proibizione della legge che dice: Non ucciderai (Es 20,13), specialmente per il fatto che non si soggiunge «Il tuo prossimo», come quando ci proibisce la falsa testimonianza, dicendo: Non dirai falsa testimonianza contro il tuo prossimo (Es 20,13.16)... Vi sono alcuni che vorrebbero estendere questo precetto anche alle bestie, tanto che, in virtú di esso, non ci sarebbe lecito ucciderne nessuna. Ma perché allora non anche alle erbe, a tutto ciò che si fissa con le radici alla terra e cosí si nutre? Anche questo genere di esseri, per quanto privi di sensibilità, si dice che vivono, e pertanto possono anch'essi morire; possono perciò anche venir uccisi, se si usa loro violenza; cosí dice l'Apostolo, quando parla di semi: Quello che tu semini non ha vita, se prima non muore (1Cor 15,36), e nel salmo troviamo scritto: Uccise le loro viti con la grandine (Sal 78,47). Quando poi udiamo: «Non uccidere», pensiamo forse che sia un delitto svellere un virgulto, accettando cosí, da mentecatti, l'errore manicheo? Via queste pazzie!
Perciò quando leggiamo «Non uccidere», se non lo riteniamo detto anche per le piante, perché non hanno sensibilità, non lo è neppure per i rettili, i volatili, gli animali natanti e deambulanti, perché a loro non è dato di avere in comune con noi la razionalità. Perciò, per rettissima disposizione del Creatore, la loro vita e la loro morte è subordinata al nostro uso; resta perciò che intendiamo solo dell'uomo quel «Non ucciderai»; non puoi uccidere un altro uomo, perciò neppure te stesso. Infatti chi uccide se stesso, non uccide altro che un uomo... tutti coloro che hanno perpetrato in se stessi questo crimine, sono forse da ammirare per la grandezza d'animo, ma non sono certo da lodare per saggezza. Quantunque, se interroghi con piú diligenza la ragione, non puoi parlare giustamente di grandezza d'animo, quando qualcuno, che non sa sopportare la sorte aspra o le colpe altrui, uccide se stesso. È segno piuttosto di mente inferma, che non riesce a sopportare o la dura schiavitú del corpo, o la stolta opinione del volgo; e si deve giustamente dire che è maggiore la grandezza d'animo di chi sa sopportare una vita travagliata, piuttosto che fuggirla, e sa disprezzare il giudizio umano - soprattutto del volgo, tutto avvolto per lo piú nella caligine dell'errore - per la purezza e la luminosità della sua coscienza...
Vi sono molti che si sono uccisi per non cadere nelle mani dei nemici. Non chiediamo solo se ciò fu fatto, ma se si doveva fare: la ragione retta, infatti, deve essere anteposta anche agli esempi; ma con essa concordano altri esempi, quelli cioè tanto piú degni di imitazione, quanto piú eccellenti per religiosità. Non fecero cosí i patriarchi, non i profeti, non gli apostoli: lo stesso Signore Cristo, quando li ammoní di fuggire di città in città nella persecuzione, poteva anche esortarli a infierire contro se stessi per non cadere nelle mani dei persecutori. Ma se egli ciò non comandò, né ammise che in questo modo emigrassero dalla vita coloro a cui aveva promesso di preparare in cielo dimore eterne, qualsiasi esempio ci oppongano i pagani che ignorano Iddio, è chiaro che non è lecito seguirlo agli adoratori dell'unico e vero Dio...
Vi furono uomini fortissimi e nobilissimi, difensori della patria terrena, cultori non fallaci degli dei purtroppo falsi, fedelissimi ai loro giuramenti, che seppero uccidere, per consuetudine e per diritto di guerra, i nemici vinti; vinti a loro volta dai nemici, non vollero uccidere se stessi, e pur non temendo affatto la morte, preferirono sopportare il nemico vincitore che dar morte a se stessi. Tanto piú i cristiani, che adorano il Dio vero e aspirano alla patria superna, si tratterranno da questo delitto, se la disposizione divina, per metterli alla prova o purificarli, li assoggetterà per qualche tempo ai nemici. Nella loro umiliazione non li abbandona l'Altissimo, che per loro è venuto in tanta umiliazione; e principalmente quelli che nessuna potestà militare né codice di guerra obbliga a uccidere il nemico vinto. Che errore perverso è dunque questo che va diffondendosi: che un uomo cioè uccida se stesso, o perché il nemico peccò contro di lui, o perché non pecchi, pur non osando uccidere lo stesso nemico che peccò o che peccherà?
Questo diciamo, questo affermiamo, questo in ogni modo approviamo: nessuno deve dare a se stesso volutamente la morte perché non gli avvenga, credendo di fuggire ai mali temporanei, di cadere in quelli eterni. Nessuno deve farlo per un peccato altrui, perché non cominci ad averne uno gravissimo personale chi veniva macchiato solo dal peccato degli altri; nessuno per i suoi peccati trascorsi, perché in questo caso ha piú bisogno di vita, per poterli curare con la penitenza; nessuno quasi per desiderio di una vita piú alta che spera dopo la morte, perché chi è reo della propria morte non sarà certo accolto, dopo di essa, da una vita migliore» (cfr. AGOSTINO, La città di Dio, 1,20.22.24.26).